Wildpeace, citato da Papa Leone a Natale
1 mese ago · Updated 1 mese ago

Quando papa Leone, nel messaggio Urbi et Orbi del Natale 2025, ha citato Wildpeace, molti hanno ascoltato quelle parole come si ascolta una voce che arriva da lontano, antica e insieme terribilmente attuale. Dietro quei versi c’è Yehuda Amichai, uno dei più grandi poeti del Novecento, forse il poeta che più di ogni altro ha saputo dire la guerra senza retorica e la pace senza illusioni. Non la pace delle bandiere e delle firme, ma quella fragile, stanca, necessaria, che nasce nel cuore umano quando l’entusiasmo è finito e resta solo il desiderio di sopravvivere.
Amichai è riconosciuto come il più importante poeta israeliano moderno, uno degli autori che hanno plasmato la letteratura ebraica contemporanea. I suoi libri vendevano circa quindicimila copie ciascuno, in un Paese dove i lettori di ebraico erano appena tre milioni: numeri da bestseller. Tradotto in oltre quaranta lingue – dall’inglese al giapponese, dal cinese al nepalese – è stato definito dal suo traduttore Robert Alter «il poeta ebraico più tradotto dai tempi di re Davide». Eppure, dietro questa fama mondiale, resta sempre la voce di un uomo che parla come un padre, un soldato, un figlio della storia.
Nato in Germania nel 1924 con il nome di Ludwig Pfeuffer, Yehuda Amichai cresce in una casa piena di musica e poesia: Goethe, Schiller, Heine. La Bibbia entra presto nel suo immaginario, fino a sovrapporsi ai paesaggi tedeschi dell’infanzia: una valle assolata diventa quella di Davide e Golia, un fiume sembra uscire dalle Scritture. L’antisemitismo, però, è già presente, prima ancora di Hitler: insulti, pietre, l’ordine gridato per strada – «Andatevene in Palestina». Nel 1936 la fuga, l’esilio, la nuova vita in Palestina. La lingua madre è il tedesco, ma l’ebraico diventa presto la lingua dell’anima.
La guerra segna per sempre la sua poesia. Combatte nella Seconda guerra mondiale e poi nel conflitto del 1948 con l’esercito israeliano. Da quell’esperienza nasce una consapevolezza dolorosa, che ritorna in Wildpeace: «So che so uccidere, questo mi rende adulto». È una frase terribile, ma necessaria. Per Amichai, l’età adulta non è eroismo, è responsabilità tragica: sapere che uccidere è sbagliato, ma che a volte può diventare obbligo per difendere la vita. Intanto, suo figlio gioca con una pistola giocattolo che dice “mamma”. In questa immagine, così semplice e crudele, c’è tutta la contraddizione del mondo.
La pace, per Amichai, non è il cessate il fuoco che permette ai killer di ricaricarsi, né la favola del lupo e dell’agnello. Non è neppure la grande utopia delle spade trasformate in aratri. La sua è una pace minore, più umana: «come nel cuore, quando l’eccitazione è finita e si può parlare solo di una grande stanchezza». È sollievo, non felicità. È una tregua dell’anima. Un «piccolo riposo per le ferite – chi parla di guarigione?».
Eppure, dentro questa stanchezza, Amichai non rinuncia alla speranza. Sa che il dolore non scompare: «l’urlo degli orfani passa di generazione in generazione come in una staffetta: il testimone non cade mai». Ma crede che la pace debba arrivare come i fiori selvatici, senza proclami, senza timbri ufficiali, perché «il campo ne ha bisogno». Da qui il nome che papa Leone ha riportato al centro della coscienza mondiale: wildpeace, pace selvatica, pace dei campi, pace della vita donata da Dio.
La forza di Amichai sta anche nello stile. La sua poesia è accessibile solo in apparenza. In ebraico gioca con i livelli della lingua, con i suoni, con allusioni bibliche densissime. Eppure riesce a parlare a tutti. Non a caso è stato poet in residence a Berkeley, alla New York University, a Yale; Yitzhak Rabin citò una sua poesia nel discorso di accettazione del Nobel per la pace. In Italia, le sue Poesie tradotte da Ariel Rathaus per Crocetti sono diventate un classico continuamente ristampato.
Amichai diceva che tutta la poesia è politica, perché tutta la poesia è risposta umana alla realtà. Anche una tazza di tè, se guardata davvero, parla della storia in cui viviamo. Per questo la sua voce, a venticinque anni dalla morte avvenuta a Gerusalemme nel 2000, continua a risuonare. Nel Natale 2025, citato dal Papa, Amichai è tornato a parlare al mondo non come ideologo, ma come uomo ferito che non smette di credere.
Forse è proprio questo che rende la sua poesia necessaria oggi: non promette salvezze facili, non cancella il male, non chiude le ferite con slogan. Chiede solo che la pace arrivi, un giorno, come un fiore selvatico. Senza rumore. Perché il campo – il mondo, l’umanità – non può farne a meno.
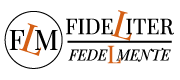


Articoli correlati