Si chiude il 2025, anno di guerre e di caos internazionale
1 mese ago · Updated 1 mese ago

Si chiude il 2025 e il bilancio che il mondo consegna alla storia è cupo, frammentato, attraversato da una violenza che non è più eccezione ma linguaggio ordinario delle relazioni internazionali. Non è stato un anno di un solo conflitto, ma di molte guerre sovrapposte, di crisi che si sono alimentate a vicenda, disegnando un presente in cui l’instabilità è diventata struttura.
Le guerre non sono tutte uguali. Alcune restano locali, altre si estendono a intere regioni, altre ancora riscrivono gli equilibri globali. Ma nel 2025 tre conflitti hanno segnato l’anno più di ogni altro, imprimendo al calendario un colore scuro e persistente: l’Ucraina, Gaza e il Sudan. Tre fronti diversi, tre storie lontane, un unico filo conduttore: la dissoluzione delle regole che per decenni avevano contenuto la forza.
La guerra in Ucraina ha continuato a essere il grande cratere europeo. I numeri parlano da soli: oltre dodicimila civili uccisi nel solo 2025, un aumento sensibile rispetto all’anno precedente, mentre il prezzo pagato sul piano militare, soprattutto dalla Russia, ha raggiunto livelli senza precedenti dall’inizio dell’invasione. Centinaia di migliaia di morti, con un’accelerazione drammatica negli ultimi mesi. Intanto la guerra ha continuato a produrre onde lunghe: milioni di profughi, economie devastate, una sicurezza continentale rimessa in discussione dalle fondamenta. Non è più soltanto un conflitto di logoramento: è il luogo in cui si decide la grammatica futura della sicurezza europea.
Se l’Ucraina è stata la guerra che ha infranto le illusioni dell’Europa, Gaza è stata quella che ha scosso il mondo intero. La violenza nella Striscia, estesa anche alla Cisgiordania, è risultata nel 2025 la più letale, la più diffusa, la più carica di rischio sistemico. Qui la guerra non è solo scontro armato, ma implosione istituzionale, crisi umanitaria permanente, detonatore regionale. Nessuna tregua può reggere se non si traduce in un assetto politico riconoscibile; nessuna sicurezza è duratura se non è sostenuta da istituzioni capaci di governare il dopo. Gaza non riguarda solo Israele e Palestina: investe l’intero equilibrio mediorientale, dalle alleanze regionali al contenimento delle milizie, fino alla fragile architettura degli accordi diplomatici costruiti negli ultimi anni.
La terza grande guerra del 2025 è anche la più silenziosa: il Sudan. Una guerra civile che raramente occupa le prime pagine, ma che ha prodotto una delle peggiori catastrofi umanitarie contemporanee. In poco più di due anni i morti stimati hanno superato quota centocinquantamila, mentre gli sfollati interni hanno raggiunto cifre impressionanti e milioni di persone hanno cercato rifugio oltre confine. È il conflitto che meglio racconta il paradosso del nostro tempo: tragedie immense che restano ai margini dello sguardo globale, pur contribuendo in modo decisivo all’instabilità di intere aree.
Attorno a questi tre epicentri, il 2025 ha visto moltiplicarsi focolai e tensioni: il Libano e la Siria colpiti da attacchi ripetuti, lo Yemen intrappolato in una guerra senza fine, l’Iran coinvolto indirettamente nel confronto regionale, le frizioni armate tra India e Pakistan, tra Thailandia e Cambogia, il conflitto cronico nella Repubblica Democratica del Congo. In Birmania, la frammentazione ha raggiunto livelli estremi, con oltre un migliaio di gruppi armati attivi sul territorio. E poi i Paesi segnati dalla violenza politica più che dalla guerra classica: Haiti ed Ecuador, simboli di Stati sotto assedio interno. In Nigeria, l’escalation jihadista ha riportato l’Isis al centro della scena, provocando anche interventi militari esterni.
Questo scenario di conflitti diffusi si è intrecciato con un cambiamento profondo del quadro geopolitico. Nel 2025 gli Stati Uniti di Trump hanno progressivamente ridotto il proprio impegno internazionale, ritirandosi da programmi di cooperazione, aiuti e sostegno multilaterale che avevano caratterizzato decenni di politica estera. Al tempo stesso, in molte aree del mondo, si è rafforzata l’ostilità verso le economie aperte e verso quell’idea di globalizzazione che aveva promesso integrazione e pace, ma ha finito per produrre nuove disuguaglianze e nuove paure. I nazionalismi, spesso in versione populista, hanno trovato terreno fertile, proponendo un ritorno a confini rigidi e sovranità esclusive.
Il risultato non è un semplice ritorno al passato, ma qualcosa di più complesso. Non esiste più un unico centro di comando globale. Il potere si distribuisce secondo geometrie nuove, mutevoli, dove Stati, multinazionali, reti finanziarie, infrastrutture critiche, organizzazioni criminali e attori armati non statali concorrono a modellare lo spazio mondiale. I paradisi fiscali continuano a proteggere grandi patrimoni, le catene di approvvigionamento vengono ridisegnate per aggirare dazi e sanzioni, il crimine organizzato si muove con la stessa agilità delle imprese globali. La geopolitica non è più solo il gioco delle grandi potenze: è la mappa di come il potere si esercita, si nasconde, si impone nello spazio.
L’Europa, in questo quadro, appare esposta. Per anni ha creduto che la norma potesse sostituire la forza, che il diritto bastasse a garantire la pace. L’Ucraina ha infranto questa convinzione. La difesa è tornata al centro dell’agenda politica, l’autonomia strategica ha smesso di essere uno slogan. Ma resta una contraddizione profonda: l’Unione regola mercati e piattaforme, ma fatica a presidiare mari, cavi, corridoi logistici. È una potenza normativa in un mondo che chiede anche capacità coercitive e resilienza sistemica.
Il Medio Oriente, dal canto suo, mostra che deporre le armi non equivale a risolvere le cause dei conflitti. La demilitarizzazione non sostituisce la legittimità, l’amministrazione tecnica non è governance. Senza istituzioni condivise, sostenute da attori capaci di farle rispettare, ogni cessate il fuoco resta fragile.
Anche l’economia globale riflette questo disordine. Non siamo di fronte alla fine della globalizzazione, ma alla sua trasformazione. Le strutture contano più degli eventi, insegnava la storia economica di lungo periodo. E oggi alcune strutture esistono – mercati integrati, monete comuni – mentre altre, come una vera capacità industriale critica e una difesa condivisa, restano incompiute.
Già trent’anni fa, studiosi lungimiranti avevano intravisto questo scenario: un mondo in cui la ricerca del profitto non sarebbe stata più l’unico motore delle decisioni statali, sostituita dal ritorno di identità, nazionalismi, fratture etniche, linguistiche e religiose. Il 2025 sembra confermare quella previsione, consegnandoci un “nuovo disordine mondiale” in cui i fronti di crisi si moltiplicano più velocemente della capacità di comprenderli.
Eppure, dentro il caos, esistono anche segnali. Le tregue imperfette non chiudono i conflitti, ma offrono spazi di ristrutturazione. Le crisi non sono solo prova di impotenza, ma stimolo a ripensare politiche industriali, sicurezza, istituzioni. La volatilità dei mercati, come ogni segnale, può essere letta e incorporata.
Si chiude così il 2025: non come l’anno della fine di un’epoca, ma come quello in cui è diventato impossibile fingere che l’ordine precedente esistesse ancora. Il mondo entra nel futuro senza mappe definitive, costretto a reinventare regole, equilibri e responsabilità. Capire la contemporaneità, oggi, significa accettare questa complessità e riconoscere che la pace non è assenza di guerra, ma costruzione faticosa di regole condivise. Regole che, nel 2025, appaiono più che mai contese.
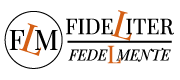
Articoli correlati